L’estate della laurea la passai con la mia migliore amica fra Barcellona, Parigi e Berlino. Poi le ultime due settimane ci trasferimmo a casa sua al mare per decidere cosa avremmo fatto del nostro prossimo futuro. Grandi discorsi serali davanti a bicchieri sempre pieni di vino, grandi progetti e sogni. Lei si sarebbe trasferita a Londra, avrebbe fatto la cameriera per un po’ di tempo e intanto avrebbe lucidato il suo inglese prima di proporsi come traduttrice da qualche parte. Io non lo so cosa avevo in programma di fare all’epoca, ma di sicuro non mi è mai passato per la mente di andarmene da Roma: detesto così tanto questa città che non potrei vivere senza. Una sera ci venne a trovare suo cugino, appena tornato da New York. Si era laureato là ma non era per niente snob e soprattutto era bellissimo. Lavorava a Roma in una rivista di Ippica, non sapeva niente di cavalli ma il suo inglese aveva affascinato tutta la redazione che pur di avere all’occhiello un laureato newyorchese gli concesse con gioia uno stipendio mensile a tempo indeterminato. Lui aveva bisogno di soldi. La sua famiglia non era ricca, salvo una zia di Berna che gli aveva pagato l’università alla morte del padre. Tutti lavoravano a casa sua, e io finalmente sentivo che qualcuno di importante era entrato nella mia vita: una persona onesta, che non ha paura di faticare per conquistare la sua indipendenza. In breve andammo a vivere insieme in un piccolo monolocale in affitto. Io davo ripetizioni di filosofia a un paio di ragazzini che mi chiedevano se Kant fosse il nuovo portiere della Nazionale tedesca, e lui andava tutti i giorni in redazione a tradurre le ultime notizie ippiche che riusciva a trovare da ogni parte del mondo. Quando tornava era stanco, sempre stanco. Così la sera non si usciva mai. Il week-end era il suo giorno di relax e il relax consisteva nello svegliarsi tardi la mattina, saltare il pranzo e poi mettersi a dipingere la collezione di soldatini medievali che pagavano l’affitto sulla mensola vicino alla televisione con una quantità di acari e polvere che seguiva gli aumenti del mercato immobiliare. Insomma, almeno erano onesti. Io stavo bene, mi piaceva occuparmi del nostro buco-con-tutti-i-confort che chiamavo “roulotte”. Mi piaceva quando tornavo a casa dopo di lui e trovavo un’insalata di pomodori tutta per me, nonostante i pomodori la sera non sia mai riuscita a digerirli. Il giovedì era il giorno del film a noleggio: un film a settimana non può incidere sul bilancio che tenevamo sempre sotto controllo. Non mi arrabbiavo nemmeno quando ogni volta che nominavo una delle mie tre amiche, lui mi chiedeva sempre le solite informazioni per cercare di capire di chi stessi parlando. Ah quanto sarebbe stato più facile se avesse prestato attenzione ai nomi propri di persone a me care! Quel clima domestico anni Cinquanta mi aveva contagiato tanto da sentire la necessità di trasformare la nostra roulotte in una casa vera: ridipingere, comprare delle tende che non fossero di plastica, trasformare quel cumulo di cuscini in un vero divano con dei teli colorati, mettere qualche pianta sul terrazzino della finestra della cucina e insomma abbellire un po’ quel buco che con tutte le buone intenzioni sembrava arredato con pezzi che il padrone di casa aveva rimediato nei cassonetti sotto l’angolo. Chiaramente queste cose costavano troppo e lui non se la sentiva di spendere i suoi guadagni per una casa non sua. Avrebbe invece messo tutto da parte per potersi comprare un giorno una casa decente in cui smettere di sentirsi un precario. Un sentimento nobile, per carità, che io stimavo e appoggiavo anche con i miei piccoli ricavi. Ma un paio di tende nuove non potevano mandarci in bancarotta, mi dicevo e gli ripetevo. L’ultima scenata avvenne quando mi convinsi che l’acqua del rubinetto mi faceva venire mal di pancia e decisi che avrei comprato una cassa di acqua al supermercato ogni settimana. Questo era uno spreco. Così gli spiegai l’importanza dei soldi che devono servire anche per soddisfare qualche capriccio. Ma io ero diventata la cicala e lui la formica. Mi chiusi la porta alle spalle sentendo un anatema incombere sulla mia testa: “Quando finirà l’estate e tu smetterai di cantare, non venire a bussare alla mia porta in cerca di cibo”. Beh, non erano queste le parole, lui non sapeva di essere la formica della favoletta proverbiale. Un anno più tardi la mia amica, che intanto si era definitivamente trasferita a Londra, in una lunga telefonata di rimpatriata fra le varie cose mi disse che suo cugino, il mio ex, aveva ereditato un bel po’ di denaro dalla zia di Berna che non aveva figli. Forse adesso anche la formica aveva iniziato a canticchiare, magari sotto la doccia e solo per il tempo di uno shampoo, però forse anche a lei erano spuntate un bel paio di corde vocali.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
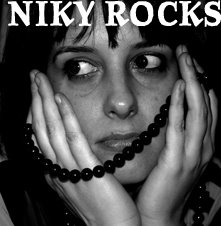


Nessun commento:
Posta un commento